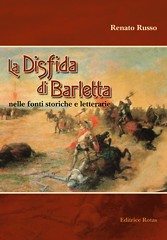 LA
PAROLA ALLA STORIA LA
PAROLA ALLA STORIA
Un testo su La Disfida di Barletta nelle fonti storiche e letterarie
per rispondere ai detrattori e per tentare di colmare, fra storia e
memoria, il vuoto informativo finora esistente sulla Disfida
Per celebrare questo V Centenario della Disfida, già da un paio
d’anni m’ero accinto a scrivere un libro su Come si viveva
a Barletta ai tempi della Disfida, monografia che dovrebbe vedere la
luce per la fine dell’anno. E l’avrei terminato anche prima,
se non fosse stato pubblicato il saggio di un noto storico, Giuliano
Procacci, il quale ha offerto della Disfida una chiave di lettura riduttiva,
per usare un’espressione eufemistica. Purtroppo il suo testo,
ancorché piccolo, contiene numerosi riferimenti e tendenziose
illazioni dirette a presentare la Disfida di Barletta come il risultato
di una perfetta orchestrazione intesa a trasformare un fatterello
in un evento.
E non era forse lo stesso autore che, nella prima seduta della Commissione
Nazionale Filatelica per l’approvazione delle ricorrenze celebrative,
bocciava la proposta di dedicare un francobollo al V Centenario dell’avvenimento?
Decisione per fortuna riconsiderata per il diretto intervento del
ministro.
Purtroppo per noi, questo piccolo insidiosissimo libro, pubblicato
da un editore dal nome molto conosciuto - Bruno Mondadori - ha fatto
il giro delle librerie e delle edicole d’Italia, è entrato
a far parte di pressoché tutte le biblioteche universitarie
e scolastiche italiane, ma soprattutto ha profondamente influenzato
gli autori delle terze pagine delle testate nazionali (come il “Corriere
della Sera”) che hanno presentato la Disfida come una rissa d’osteria,
un evento banale e insignificante che andava rimosso dalla coscienza
nazionale.
Ha cominciato il 16 dicembre del 2001 lo storico Ettore Botti sul “Corriere
della Sera” scrivendo un pezzo a sei colonne su terza pagina
nazionale con un titolone su sei righi così concepiti: Il pamphlet
di Giuliano Procacci prende di mira e ridimensiona un episodio consacrato
di storia patria. Disfida di Barletta, una lite da osteria. Come trasformare
un fatterello in evento. Ed ecco l’incipit dell’articolo.
Una campagna stampa ben orchestrata, qualche programma televisivo dal
richiamo seducente, l’avallo di esperti che sembrano indipendenti,
la reiterazione dei dati, immagini e concetti fasulli fino ad accreditarli
come autentici, il rimando da un testimonial all’altro perché si
diano man forte in un valzer autoreferenziale, all’apparenza
casuale. Si sa che oggi si fa così per trasformare un fatterello
in evento. Ma la deformazione della realtà è sempre esistita
e, mutati il sistema e gli strumenti da manipolare, il quadro, cinque
secoli addietro, è pressappoco lo stesso. Giuliano Procacci
si diverte a sostenerlo in un irriverente e piacevole pamphlet, pubblicato
da Bruno Mondadori, nel quale prende di mira un episodio ormai consacrato
nella nostra storia patria: la disfida di Barletta. E cerca di compiere
la sua revisione, smontando pezzo per pezzo le versioni ufficialmente
accreditate e sostituendole con altre più modeste che potrebbero
essere più aderenti a ciò che realmente accadde.
Riprendeva il tema, poco dopo, da ben più alta cattedra, Franco
Cardini il quale, sull’“Avvenire“ del 5 gennaio del
2002, recensendo il volume del Procacci, scriveva lui pure un pezzo
a tutta pagina, su La Disfida di Barletta e l’uso mistificante
della storia. Il pericolo di cadere nel ridicolo, di cui riporto l’esordio.
Le sciocchezze che già dall’indomani dell’infausto
11 settembre 2001 si sono dette a proposito delle crociate, della jihad
e dell’Islam, hanno ricondotto in primo piano il problema dell’uso
della storia e delle relative mistificazioni. Ch’è poi
fondamentale nella misura in cui l’uso mistificante del passato è entrato
sovente - anche in tempi non lontani - nel circolo dei nostri valori
civici, o di quelli che tali si consideravano. Per esorcizzare il rischio
di ricadere di nuovo nel ridicolo, o di restare vittime di nuove trappole
massmediali, un discreto vaccino può essere la lettura di un
libretto tanto erudito e storicamente attendibile quanto dissacratorio
e disincantato, uscito dalla penna d’un nostro illustre storico,
Giuliano Procacci, studioso schivo e non troppo prolifico, che negli
anni si è a mio avviso fin troppo tirato in disparte. Giuliano
Procacci sembra tornare ora sulle orme del vecchio Massimo d’Azeglio,
autore com’è noto d’un vecchio e a suo tempo molto
letto romanzo storico, l’Ettore Fieramosca, in cui si raccontavano
le vicende della celebre disfida di Barletta e del suo eroico protagonista,
un cavaliere tanto magnanimo nelle gesta quanto, ahimè, risibile
nel nome. Difatti, nel 1965, ci avrebbe pensato Pasquale Festa Campanile
a rileggere la disfida e i suoi eroi in un film dai toni al quanto
brancaleoneschi.
E così via. Vi risparmio altri titoli, ma non l’amara
constatazione che, con articoli del genere, si faceva via via strada,
nel cuore e nelle menti, dei nostri studiosi e dei nostri lettori
(parlo di centinaia di migliaia di persone diffuse su tutto il territorio
nazionale), una valutazione riduttiva della Disfida.
Ma non è finita. Ricorderemo così, come negli ultimi
tempi si sia fatta strada, nei mass media, sempre dopo la lettura del
Procacci, la convinzione che la disfida fu vinta non per il valore
dei campioni italiani, ma per la loro furbizia, tesi invero sostenuta
dal d’Auton (l’unico francese a parlare di questa storia!)
e ripresa volentieri dal nostro storico.
Tralasciamo per amor di patria di riportare la successione degli
ultimi articoli, limitandoci ad una breve ma bruciante valutazione
del “Corriere
della Sera” del 16 febbraio del 2003 a firma di Luigi Quaranta,
sugli aspetti caciaroni e popolari della sfida, basati sulla gastronomia
e sul vino, su golose disfide riservate ai pasticcieri, sui tornei
di tennis, di biliardo e d’atletica leggera, che culmineranno
a settembre nel rinato certame cavalleresco.
La parola alla storia
E via! M’è parso troppo. Cosa dovevamo fare, continuare
a tacere in omaggio ad un malinteso senso di prudenza? E all’inizio
abbiamo taciuto, anche perché ìmpari a misurarci sia
con la caratura degli storici in questione, che con le testate e gli
editori, e le loro esternazioni. Ma poi, alla fine, ci siamo detti
che la misura era colma e che era venuto il momento di ricordare che
la Disfida di Barletta è un episodio noto in tutto il mondo,
che ne hanno parlato centinaia di cronisti, storici, scrittori, nel
corso di cinque secoli, cominciando dal più grande di tutti,
quel Francesco Guicciardini che ne esaltò il significato emblematico
rammentandoci che quei tredici cavalieri, “eroi loro malgrado”,
eran comunque degni che ogni italiano procuri in sé che i loro
nomi trapassino alla posterità mediante l’istrumento delle
lettere. O il Machiavelli quando, nientemeno che nel Principe (XXV
capitolo) ricorda come quegli stessi italiani che quando si viene agli
eserciti non compariscono, risultano invece superiori con le forze,
con la destrezza e con lo ingegno, quando si misurano ne’ duelli.
Per non parlare dei numerosi altri che si sono diffusi e sulla storia
e sul romanzo della sfida, tanti e così numerosi da ricavarne
un libro, uscito in questi giorni in libreria, La Disfida di Barletta
nelle fonti storiche e letterarie. Come dire: La parola alla storia,
e ripetere, col Gregorovius, uno dei grandi storici dell’Ottocento
europeo: Senza dubbio questo campo di battaglia di uomini valorosi
ove non combatterono che ventisei guerrieri in tutto, merita di essere
calpestato con un sentimento di più viva emotiva partecipazione,
che non cento altri campi di battaglia, sia pure più cruenti,
ove vennero al cozzo e versarono il proprio sangue interi eserciti
per il capriccio di poche teste coronate o per le insaziabili brame
di ingordi conquistatori. O è stato “orchestrato” anche
il Gregorovius?!
Renato Russo
<< vai all'indice
del canale |