La battaglia
Schema topografico e cenni storici
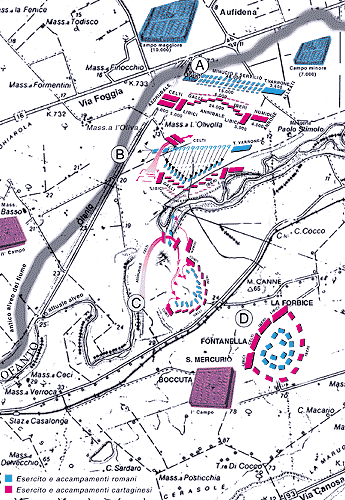 A - Lo schieramento iniziale A - Lo schieramento iniziale
Completati gli schieramenti, si fronteggiavano sul campo 86.000
Romani (di cui 6.000 cavalieri) contro 50.000 Cartaginesi (di
cui 10.000 cavalieri),
i primi comandati dai consoli Lucio Emilio Paolo e Caio Terenzio
Varrone, dai proconsoli Cneo Servilio Gemino e Minucio Rufo;
i secondi da Annibale,
Magone, Asdrubale, Annone e Maarbale. Fu la battaglia nella quale,
più che in altre, rifulse il genio militare del Cartaginese.
B - Lo sfondamento della fanteria al centro
Completato lo schieramento, Annibale prese l’iniziativa e impartì un
ordine secco e squillante. Levatosi un grido (clamore sublato), iniziò la
battaglia.
Il comandante cartaginese comandò alle due ali della cavalleria
di attaccare gli squadroni romani, e alla fanteria gallo-iberica di
avanzare al centro, mentre i fanti libici restavano arretrati, in attesa
dello sviluppo dell’azione. Era il momento decisivo dello sviluppo
strategico della battaglia.
Mentre le fanterie romane cercavano di penetrare sempre più in
profondità dentro il varco aperto dall’azione di sfondamento,
le due cavallerie si davano battaglia sulle ali.
C - La verticalizzazione dell’attacco romano e l’inizio
dell’accerchiamento
La fanteria romana, frattanto, al centro, ingagliardita dall’iniziale
successo, nella poderosa spinta in avanti, aveva modificato l’assetto
frontale iniziale, in una colonna che penetrava con la forza di un
possente cuneo nelle file del nemico, sospinto verso sud sud-est, cioè verso
l’area antistante il ponticello che oggi immette sulla strada
che porta all’Antiquarium. Questo tratto di percorso, dall’inizio
del combattimento sulla sponda del fiume, fino all’ingresso
nei valloncelli di Canne (forse 5-600 metri in tutto), segnato da
accaniti
combattimenti e da un gran numero di morti da entrambe le parti.
D - Completamento dell’accerchiamento e massacro finale
Ormai l’accerchiamento era completato e Annibale badò che
durante la manovra le forze cartaginesi fossero egualmente distribuite
perché non si aprissero varchi alla fuga del nemico. Compressi
in uno spazio che si faceva sempre più angusto, ostinati in
una forsennata quanto vana resistenza, i legionari si accalcavano
gli uni sugli altri, fra montagne di cadaveri e gemiti di moribondi,
in
una mischia gigantesca dove migliaia di corpi coprivano di sangue
la pianura riarsa. In quella tragica confusione, era impossibile
dare
ordini.
Per Roma fu la più spaventosa disfatta della sua storia Ad Annibale
la vittoria diede la padronanza dell’Italia meridionale e la
prospettiva di una lunga egemonia punica sul Mediterraneo. Ma era una
prospettiva di corto respiro perché Canne, ricordata come la
più cruenta delle sconfitte patite dalle legioni romane, segnò anche
il momento saliente dell’epica lotta che per oltre un secolo
avrebbe contrapposto le due maggiori potenze del Mediterraneo.
Cenni tratti da Canne 216 a.C. La più grande battaglia dell’antichità,
di Renato Russo, Editrice Rotas, Barletta, maggio 2001, pp. 72, e
6
<< vai all'indice del canale
|