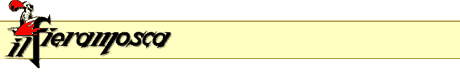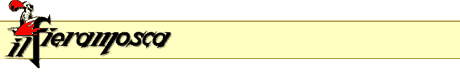|
Via Fanfulla da Lodi
Tito da Lodi soprannominato Fanfulla o Bartolomeo Fanfulla da Parma?
Questo è uno dei tanti misteri che avvolgono i campioni dell’epica
Disfida di Barletta.
Le prime notizie di Fanfulla risalgono al 1499, quando la sua presenza
viene registrata nell’assedio di Pisa al seguito del capitano Paolo
Vitelli, assoldato dai fiorentini. In seguito il nostro eroe passa al
servizio del duca di Termoli, uno dei condottieri più stimati
dagli spagnoli, partecipando alle famose battaglie di Cerignola e del
Garigliano, alla presa di Sessa, Capua, Napoli e all’assedio di
Gaeta. Lo ritroviamo nel 1508 sempre con la compagnia del duca e prigioniero
dei francesi a Ravenna; in seguito si trasferisce a Milano, 1513, ed è al
servizio del conte di Potenza come alfiere o capitano di bandiera, alla
testa di cinquanta uomini e percepisce un compenso annuo di 200 ducati.
Due anni più tardi è accampato a Villafranca, in Piemonte
al seguito di Matteo Spinola. Poi lo ritroviamo a Chieti nel 1517 e l’anno
dopo è tra i milletrecento cavalieri invitati a una rassegna
di tutte le migliori lance a Napoli.
Bartolomeo Fanfulla, con tutta la compagnia, si trasferisce a Milano,
rintracciamo le sue tracce in alcuni documenti del 1524, dopo se ne
perdono le tracce.
Secondo Filippo Abignente, il compagno di Fieramosca, muore qualche
mese dopo nella guerra combattuta in Lombardia contro Francesco I re
di Francia,
poi sconfitto nella battaglia di Pavia del 1525. Per altri la fine
di Fanfulla avviene a Terracina in seguito a una banalissima caduta
da cavallo.
Massimo D’Azeglio inserisce il personaggio di Fanfulla nei suoi
due romanzi: “Ettore Fieramosca” e “Niccolò de
Lapi” contribuendo ad alimentare la leggenda attorno al personaggio,
che tratteggia come svelto di mano e di lingua, temerario ma galantuomo.
Nella finzione letteraria Fanfulla muore a Marciano, piccolo comune nell’aretino,
nel 1554, ormai ottantenne, tenuto presente che ai tempi della Disfida
non poteva avere più di 30 anni.
Ma più che la data e il luogo della scomparsa del cavaliere, studiosi
e curiosi si sono soffermati sulla identificazione della città di
nascita. I più sostengono che sia nato a Lodi e la denominazione “parmigiano” fosse
generica indicando una vaga località geografica, anche perché fino
al 1515 una parte del lodigiano era incluso nel ducato di Parma e Piacenza.
A voler essere ancora più precisi Bartolomeo Fanfulla pare sia
nato a Basiasco, paesino a otto chilometri da Lodi e si chiamasse di
cognome Battistini.
In ogni caso i lodigiani conservano gelosamente nella loro pinacoteca
un ritratto databile intorno al XVII-XVIII secolo, che reca la scritta “Titus
dictus Fanfula laud.m decor Italia V. contra Gallos” e un bassorilievo,
opera dello scultore Bianchi. Al campione della Disfida hanno dedicato
una strada, una caserma, il sipario del teatro “Verdi” dipinto
da Alessadro Degrà e anche l’omonimo periodico locale.
“
Molti credettero che Parma potesse gloriarsi di aver dato i natali non
solo a Riccio, ma ben anche a Fanfulla, che seco lui fu un altro dei
tredici campioni di Quarata - scrive Scarabelli Zunti studioso di Parma
-. Per noi sarebbe ciò un gran vanto, è vero, ma tanto
non sembra accertato quantunque siavi l’autorità d’uno
scrittore anonimo testimone di veduta, quella del napoletano Summonte,
e più ancora del Guicciardini, che in Parma stessa, l’anno
1521 vide e conversò col nostro Riccio non solo, ma ben anche
con Salomone Siciliano, pur esso uno dei combattenti di Quarata…
Tutto ciò potrebbe far ritenere che tanto il Riccio quanto il
Fanfulla fossero entrambi di Parma, o per lo meno del suo contado;
ma per la discordanza in cui trovansi fra loro gli scrittori che ci
diedero
i nomi dei tredici campioni di Barletta, e privo come sono d’irrefragabili
documenti per accertare che anche il Fanfulla sia nativo od oriundo
di Parma, lo lascio a Lodi…”. (M. Ruggiero)
|