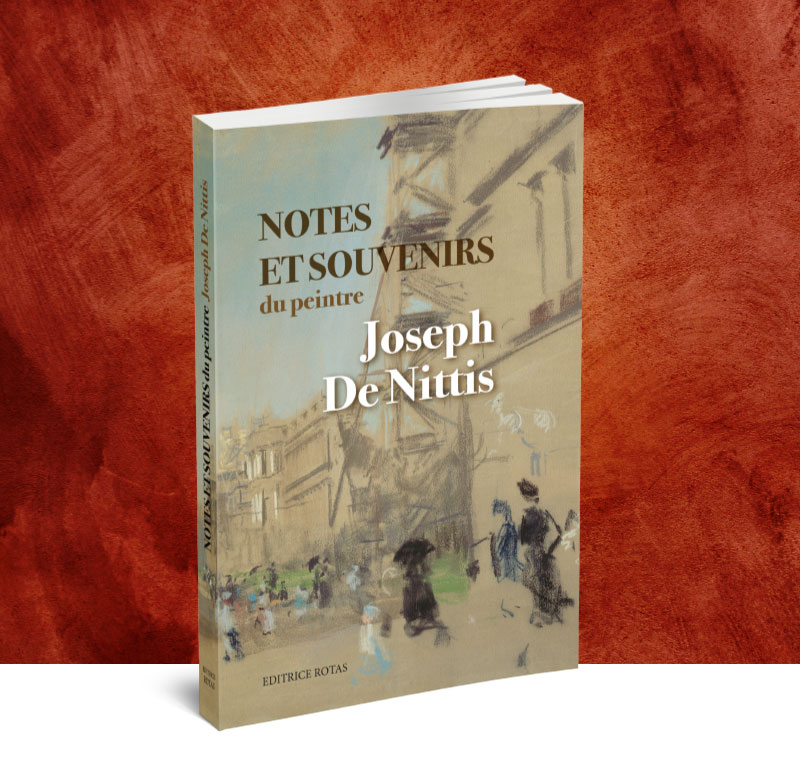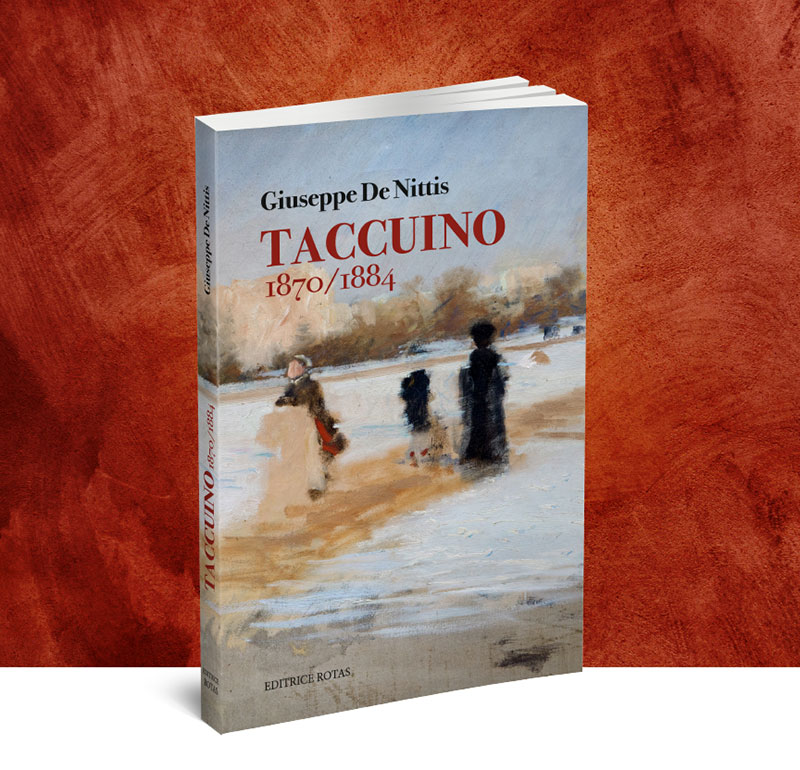21 febbraio 2020
di Renato Russo
Torna in libreria, in versione italiana ma anche
nell’originale stesura in francese, per i tipi della Rotas, il richiestissimo Taccuino di De Nittis, titolo originale Notes et souvenirs du peintre Joseph De
Nittis, pubblicato a Parigi nel 1895 presso le Librairies-Imprimeries
Réunies. L’anno precedente Léontine aveva stampato Notes et souvenirs in quattro puntate sul periodico parigino
“Nouvelle Revue”. Spesso ci si è chiesti, dopo la morte di De Nittis, del
perché della mancanza di una sua biografia. Avrebbe dovuta scriverla de Goncourt,
a cui si era rivolta Léontine, ma l’idea sarebbe abortita per la imminente
pubblicazione del suo Journal, non
sempre cordiale nei confronti della vedova. Così questi appunti, questi ricordi
che hanno tutta l’apparenza di un reportage giornalistico, a distanza di dieci anni, colmarono questo vuoto biografico.
Il Taccuino non è una ricognizione sistematica delle opere dell’artista, ma una narrazione
diaristica delle sue giornate parigine, dove traspaiono i racconti della sua
quotidianità, del suo mutevole stato d’animo, delle sue committenze, dei suoi
viaggi, pagine intense della sua vita attraverso le sue emozioni, la sua rappresentazione
artistica del bel mondo parigino.
E poi i suoi incontri con i numerosi amici,
soprattutto artisti come lui, dei quali ci tramanda dei gustosi bozzetti:
Cafiero l’amico barlettano del quale era stato compagno di scuola, il mordace Manet,
l’ambiguo Degas, il nevrotico Edmond de Goncourt, l’affabile Daudet,
l’enigmatico e contraddittorio Cecioni, il grande romanziere Zola, Dumas figlio
al quale dobbiamo il testo della famosissima epigrafe sul monumento funebre al
Père Lachaise “Ci gît le peintre Joseph De Nittis mort à trente-huit
ans en pleine jeunesse en plein amour en
pleine gloire comme les héros e les demi-dieux”.
E sullo sfondo le atmosfere
parigine, la Senna, i boulevards, le corse a Longchamps, i ricercati salotti
dove si ostentava la moda parigina, una Parigi segnata dalla presenza degli
Impressionisti, dei quali De Nittis era un antesignano, che avrebbe informato
di sé mezza Europa, un’Europa colta nel fervore dei suoi gusti (siamo all’alba
della Belle Époque), dei manifesti letterari, luogo d’incontro di artisti e
rivoluzionari. Una sorta di autobiografia breve ma intensa, bruscamente
interrotta dalla improvvisa scomparsa dell’artista.
Più che una descrizione dei suoi
quadri, emerge dalla narrazione la temperie creativa nella quale nacquero i
suoi capolavori, facendoci rivivere una condizione di singolare contemporaneità,
dove De Nittis si palesa al lettore con la carica della sua amabilità, con i
suoi slanci, la sua spontaneità.
Il testo è lieve, il racconto
s’inoltra nei ricordi attraverso una serie di bozzetti acquerellati, senza che
alcuna nota critica sulle opere ne adombri la gioiosa freschezza narrativa. E
del resto chi ha approfondito la storia della coppia, nel corso dei quindici
anni vissuti assieme, non ha potuto non cogliere la predisposizione di Léontine
al racconto diaristico attraverso appunti, ricordi ed impressioni, al contrario
di Peppino alquanto restio a parlare di sé, della sua vita e del suo lavoro.
Anche se non è improbabile che, nella sua febbrile attività, egli abbia talvolta
lui pure raccolto appunti, steso bozze di corrispondenza, annotato situazioni
particolari. Coinvolgenti le pagine che rievocano con uno stile colorito i suoi
rapporti con Barletta, dagli anni della sua adolescenza alla vivace accoglienza
dei suoi ritorni, concittadino ormai celebre.
Léontine, restata vedova, è
verosimile immaginare che abbia inventariato pure le carte del marito, memorie
anche le più remote legate alla sua infanzia barlettana, che le abbia poi unite
alle sue, conferendo al tutto, con mirabile intuito psicologico,
un’impostazione introspettiva, delineando così un testo autobiografico.
Testimonianze tratte anche dagli articoli dei giornali del tempo, come le
cronache del noto giornalista Jules Claretie.
Dai suoi articoli, estrapoliamo
una dichiarazione di straordinaria importanza, resa dall’artista al cronista
parigino, nella quale definisce i suoi rapporti non sempre facili con gli Impressionisti:
“Mi rimproverano di dipingere come loro e di avere più sostenitori di loro. Io
prendo alla leggera questo rimprovero. È certo che ho fatto in modo di
sperimentare tutte le tecniche del mio tempo, ma soprattutto osservo la natura,
che appartiene, penso, a me come a tutto il mondo. Faccio ciò che vedo, senza
preoccuparmi e con i mezzi che ho. Tutto qui. Che i miei amabili nemici dicano
tutto ciò che vogliono: questo non toglierà niente al talento che abbiamo o che
non abbiamo”.
Peccato solo che Titine non abbia
potuto utilizzare, per il suo diario, il cospicuo contenuto di una cassa di
documenti abbandonata a Parigi dall’artista in fuga nei giorni del conflitto
franco-prussiano (autunno 1870) e da lui mai più ritrovata. Della perdita della
preziosa cassa ne avrebbe dato notizia lo stesso Claretie su “La vie a Paris”
qualche giorno dopo la morte di De Nittis, mentre la fonte che ne avrebbe (44
anni dopo) diffuso il contenuto è la monografia di Vittorio Pica (1914) uscita
pochi mesi dopo la morte della vedova De Nittis.
Ma tant’è, Léontine, per la redazione
delle sue memorie, e di quelle del marito, fu costretta a servirsi dei suoi
personali ricordi, delle sue impressioni di viaggio, dei suoi appunti
inventariati nel corso di due lustri. E d’altra parte non è un mistero che
l’estrosa Titine coltivasse delle ambizioni letterarie, tant’è vero che dopo la
scomparsa del marito, essa consegnò alle stampe due romanzi scritti con una disinvolta
abilità letteraria. Non è difficile allora immaginare che della stesura di
questi ricordi essa sia stata non solo ispiratrice, ma anche coautrice,
utilizzando uno stile vivace, aderente alla schiettezza discorsiva del marito.
E c’è anzi chi sostiene, tout-court,
che dietro la firma di Giuseppe si nasconda invece quella della moglie Léontine.
Non siamo molto lontani dalla realtà.
Numerosi sono gli episodi del Taccuino nei quali De Nittis
ristabilisce un rapporto con la sua città natale, sia quando viene a fargli
visita Carlo Cafiero, sia quando - di tanto in tanto - ritorna a Barletta.
L’incontro a Parigi con Carlo Cafiero
Peppino e Carlo erano nati nello
stesso anno, nel 1846, Peppino il 25 febbraio, Carlo il 1° settembre. E non
molto distanti erano le loro case, sulla stessa via della Cordoneria (oggi Corso Vittorio Emanuele), Peppino al civico 23 e
Carlo al civico 111. Frequentavano entrambi la stessa scuola, in fondo a via
Nazareth, al secondo piano di palazzo Affaitati avendo come insegnante don
Nicola Straniero, un prete, uno dei capi del movimento risorgimentale di
Barletta. Ma ben presto le loro strade si divisero: Carlo si trasferì a Firenze
per tentare la strada della carriera diplomatica, salvo poi a ripensarci per
aderire al movimento anarchico; Peppino a Napoli presso l’Accademia di Belle
Arti per realizzare il suo sogno, ch’era quello di diventare un affermato
pittore. S’erano persi di vista, quando, nel 1870, Carlo andò a trovare il
vecchio amico Peppino nella nuova casa parigina, alla Jonchère, dove si trattenne per diversi giorni, eclissandosi
saltuariamente senza dare notizie di sé. Inducendo così al sospetto i coniugi
De Nittis che Carlo avesse una relazione con una signorina del posto. Sapranno
invece, in seguito, che Carlo era un socialista anarchico e che perciò i suoi
erano incontri politici avvolti dal riserbo più assoluto.
L’ultima volta a Barletta
Nel 1879, dopo l’Esposizione
Universale, Barletta fece coniare una medaglia d’oro in onore di Peppino e
organizzò i festeggiamenti. Peppino, in quei giorni, stava a Napoli dove fu
costretto a lasciare Titine perché seriamente ammalata presso il fratello
Vincenzo il quale si raccomandò di comportarsi “secondo convenienza”, cioè
secondo le consuetudini del buon vivere locale, ma soprattutto di parlare in
italiano e non in dialetto, come Peppino era abituato. E a proposito del
discorso, Vincenzo consegnò al fratello una grande busta che conteneva l’intervento
che Peppino avrebbe dovuto leggere. A Barletta il nostro ebbe un’accoglienza
trionfale, cominciando dal sontuoso pranzo nel corso del quale ci furono molti
brindisi e qualche discorsetto, in un clima di sussiegosa circostanza. Finché
venne il turno di Peppino il quale tirò fuori dalla tasca del paltò il suo bel
discorso preconfezionato, ma dopo qualche esitazione, gettò i fogli sul tavolo
ed esclamò che avrebbe parlato a braccio, alternando dialetto e italiano,
rompendo quel clima di ufficialità che s’era creato fra i commensali. Poi, in
serata, tutti a teatro dove si concluse la giornata con grandi panegirici del
nostro grande artista, ma sempre in un clima di festosa spensieratezza.